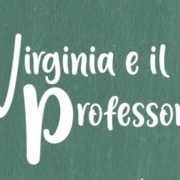I giovani e la speranza: qualche testimonianza
Dallo speciale estivo di Note di Pastorale Giovanile con l’approfondimento della proposta pastorale MGS per il 2024-25 sul tema della SPERANZA.
***
Le testimonianze non sono propriamente di “giovani”, ma di persone che sono state coordinatori del Movimento Giovanile Salesiano a livello nazionale. E l’ultima, una che lavora nella progettazione sociale di “Salesiani per il sociale”.
La speranza è nel presente: il centuplo quaggiù
Emanuele Bonazzoli *
Riflettere sulla speranza quando si è giovani e si sta guardando alla vita è un discorso: apre orizzonti, sentieri di vita, esperienze, ampi respiri e audaci scommesse. Ho vissuto tutte queste fasi nei miei vent’anni trascorsi attivamente all’interno del MGS: lo sguardo locale, ispettoriale, nazionale ed europeo hanno aperto panorami via via più ampi che hanno interrogato e plasmato la mia vita.
Riflettere sulla speranza a metà vita, da marito e papà, da adulto lavoratore con le incombenze del quotidiano, la routine che ritma le giornate, in un mondo con un suo contesto socio-economico-culturale che preoccupa, è un’altra cosa… Le difficoltà della gestione di ogni giorno, il mutuo da pagare, le scadenze e i ritmi dell’agenda, le incertezze del lavoro, tolgono smalto alla speranza.
Nel corso della vita, il valore che diamo alla speranza può assumere sfumature variabili, influenzate dalle nostre esperienze e convinzioni personali. Per lungo tempo ho interpretato la speranza come “l’attesa del futuro”, un desiderio di realizzazione che trova compimento in un domani migliore: certo, per il cristiano, ho costantemente pensato che la speranza assumesse il valore della certezza, ma l’ho sempre relegata nel tempo non ancora compiuto. La speranza nella vocazione, nel diventare insegnante, nel vivere pienamente il mio essere cristiano e salesiano cooperatore. La delusione della situazione attuale, mescolata al desiderio di qualcosa di nuovo, mi ha portato anche a pensare che inseguire la speranza fosse fuggire dal presente e dalla realtà. Tuttavia, il tempo, le esperienze e il confronto con mia moglie mi hanno condotto a una nuova consapevolezza: la speranza è innanzitutto la ricerca della presenza del Signore nel momento presente. La sua promessa è “la gioia piena” non domani, ma oggi. Ed è stato un cambio di prospettiva!
Spesso, infatti, ci concentriamo sul futuro, proiettando desideri e aspettative che, se realizzati, ci renderanno felici: investiamo tempo ed energie a dare forma a sogni che vogliamo inseguire. Se però non viviamo il nostro sogno già ora, lasciando aperte le strade alla Provvidenza e concentrandoci solo su quanto ancora ci manca per raggiungere il nostro scopo, questa prospettiva può condurci a trascurare il valore del presente, ricco di opportunità e benedizioni da apprezzare. La speranza, dunque, cessa di essere solo nell’attesa, ma diventa consapevolezza di una promessa già mantenuta, che si manifesta nei doni quotidiani e negli incontri che arricchiscono la nostra vita: non si tratta di vivere da ingenui, ma di dare la giusta dimensione alla realtà. Quante volte ci troviamo a ringraziare per ciò che abbiamo ricevuto e che viviamo? Quante volte diamo per scontati doni che viviamo quotidianamente? Quante volte ci lasciamo sopraffare dalle ansie che ci portano ad affannarci e preoccuparci come Marta, tralasciando ciò che è importante e presente? Quante volte mi è sembrato di avere sprecato una giornata in presenza di mia moglie, dei miei figli, dei miei allievi, dei miei cari, perché ho inseguito altro?
Ho scoperto che la gratitudine è il vero strumento prezioso per coltivare la speranza nel momento presente. Per fare questo devo fermarmi e rileggere il mio oggi, quotidianamente, dedicandomi dei momenti di meditazione durante i quali lascio parlare il quotidiano facendo emergere ciò che dà senso e gioia alla mia vita. Quando impariamo a riconoscere e apprezzare le piccole gioie e le benedizioni che ci circondano, ci rendiamo conto che il futuro non è il vero luogo in cui potremo trovare felicità e realizzazione; e soprattutto, il futuro non dipende (solo) da noi! Vivere il presente ci riporta alla nostra dimensione umana, di uomini amati e ci permette di ridonare a Dio il suo ruolo di Padre che si prende cura perfino degli uccelli del cielo e dei gigli dei campi. L’istante presente, quindi, diventa l’opportunità per incontrare il Signore, per percepire la sua presenza nella bellezza del creato, nelle relazioni con gli altri e nei momenti di serenità interiore.
Abbracciare il valore della speranza significa per me oggi imparare a vivere pienamente il momento presente, con gratitudine e consapevolezza. Significa riconoscere che la promessa di una vita piena e significativa è già qui, nel centuplo di gioia e benedizione che possiamo sperimentare nel nostro quotidiano. Quando impariamo a guardare oltre le nostre preoccupazioni e ansie, scopriamo che la presenza del Signore è sempre con noi, pronta a sostenerci e guidarci lungo il cammino della vita.
* 45 anni, marito e papà… e cerca di vivere al meglio questa sua vocazione. Docente di italiano per stranieri in università e insegna storia dell’arte alle scuole superiori: questo gli permette di incontrare giovani e di parlare con loro di vita e bellezza. È molto felice di fare parte di una comunità parrocchiale viva nella periferia di Milano.